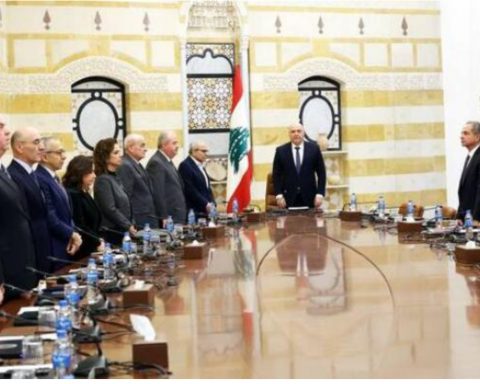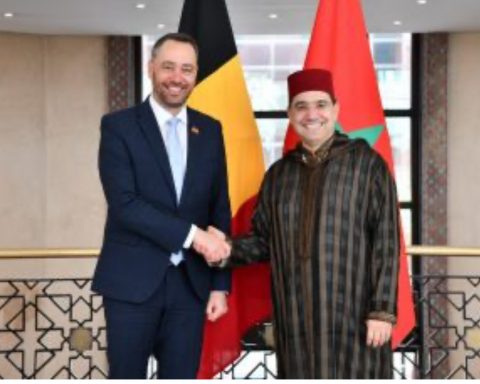La donna africana, di solito, vive in condizioni di inferiorità rispetto all’uomo.
In molte culture/realtà africane esiste la convinzione che è l’uomo che sposa la donna. La donna è sposata e in questa affermazione è racchiuso il significato del matrimonio come acquisto.
In molti villaggi, le donne sono impegnate a procurare il necessario per la famiglia, mentre gli uomini oziano per intere giornate. In Africa, la donna contribuisce ai 2/3 dello sviluppo e della ricchezza agricola, è la protagonista indiscussa del commercio: acquista, vende, baratta, sia nei mercati rurali che urbani.
Nei Paesi più poveri dell’Africa, molto frequentemente, la donna è vittima di abusi sessuali e violenze. In molti casi sono le bambine e le ragazze a dover affrontare i lunghi cammini per procurare l’acqua per l’intera famiglia. Da qui, si evince la disparità di genere che non può e non deve essere considerata come una condizione immutabile, né tantomeno naturale, così come precisato da Nelson Mandela a Trafalgar Square nel 2005, in occasione della manifestazione Make
Poverty History.
La disparità di genere è un prodotto delle azioni umane che può essere certamente superato, soprattutto attraverso un incisivo investimento nell’istruzione femminile.
L’11 luglio 2003, in occasione del secondo vertice dell’Unione Africana, gli Stati membri dell’organizzazione hanno adottato il Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, sui diritti delle donne in Africa (Protocollo di Maputo), per salvaguardare e promuovere i loro diritti.
Il protocollo, entrato in vigore nel Novembre 2005, contiene 32 articoli con i quali i paesi ratificanti si impegnano ad adeguare la propria legislazione interna includendo una serie di diritti fondamentali delle donne, tra cui il diritto alla dignità, alla vita, all’integrità ed alla sicurezza fisica.
L’articolo 2 impegna gli Stati ad eliminare ogni sorta di discriminazione nei confronti delle donne, modificando “gli schemi e modelli di comportamento socioculturali della donna e dell’uomo con l’istruzione del pubblico tramite le strategie d’informazione, d’istruzione e di comunicazione, in attesa di giungere all’eliminazione di tutte le pratiche culturali e tradizionali nocive e di qualsiasi altra pratica fondata sull’idea d’inferiorità o di superiorità dell’uno o dell’altro sesso.
Di notevole importanza è l’articolo 5 relativo all’eliminazione delle pratiche tradizionali nocive per la salute e la
dignità delle donne tra le quali si annovera qualsiasi tipo di mutilazione genitale femminile, per la prima volta formalmente considerata una violazione dei diritti umani delle donne. L’ennesima dichiarazione scritta. L’ennesima promessa non mantenuta. Ma per fortuna l’Africa al femminile sta reagendo.
Contestualmente a condizioni di vita in cui prevalgono offese, umiliazioni e soprusi di ogni genere, il mondo femminile, da diversi anni, ha iniziato ad assumere una sua specificità, riportando la donna africana a ruoli che la colonizzazione le aveva rubato. A dire il vero, anche in passato le donne avevano dimostrato il loro carattere e la loro tenacia, come nel caso della regina Anne Zingha d’Angola, che nel XVII secolo resistette per tre decenni ai conquistatori portoghesi, o
come la senegalese Ndete Yalla, che nell’Ottocento guidò la resistenza alle truppe del generale francese Faidherbe, il quale, percorse gran parte della sua carriera nelle colonie, in particolar modo nel pssedimento del Senegal. Ma anche la giovane Kimpa Vita, la “Giovanna d’Arco congolese”, che creò un movimento anticoloniale, battendosi contro tutte le forme di schiavitù.
All’età di ventidue anni finì sul rogo. E più recentemente la rivolta delle donne Aba in Nigeria e la ribellione delle donne Kom in Camerun. Femminismo e attivismo iniziano a incrociarsi, attraverso l’accesso alla produzione di conoscenza e nell’essere partecipi dei dibattiti che riguardano la politica e le nuove sfide della società contemporanea, come nel caso di Wangari Maathai prima donna africana a ricevere il Nobel per la pace, per la sua sensibilità ambientale e per aver lottato
contro la deforestazione e a difesa della democrazia e della pace. È l’inizio del movimento femminile Green Belt, contro il degrado ambientale, ma anche contro la corruzione e il “tribalismo” del partito unico di Daniel arap Moi, presidente dal 1978 al 2002. O come nel caso di Hadja Idrissa Bah, la quale, nel 2017 ha guidato una rivolta di ragazze quasi tutte minorenni per richiedere una legge che ponesse fine ai matrimoni precoci. E ancora Amina Mama, una delle
principali protagoniste del femminismo africano, direttrice dell’African Gender Institute. Per lei è necessario agire, impegnandosi a lottare per la liberazione delle donne da ogni forma di oppressione, interna ed esterna, psicologica ed emotiva, socio-economica, politica e filosofica.

Patricia McFadden, sociologa e scrittrice femminista radicale, sottolinea l’aspetto essenziale del discorso intellettuale nella pratica di resistenza femminista, del genere come “strumento femminista di pensiero”. E’ il segnale della speranza che non può rimandare al futuro, è la speranza del presente non come utopia, ma come risposta alla delusione del moderno progresso.
Non c’è speranza senza presente e avvenire. La vita vive finché c’è ancora da vivere e la speranza rappresenta l’opposizione semi astratta alle ingiustizie e alle disuguaglianze, è la dimensione che si oppone all’assurdo. In Africa, come nel resto del mondo, chi dona la vita non può e non deve continuare a soffrirla. E’ compito di ciascuno di noi sostenere e difendere coloro che, elevando le braccia in alto non fanno cadere il cielo.