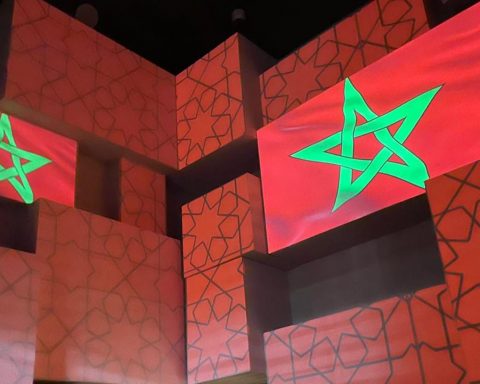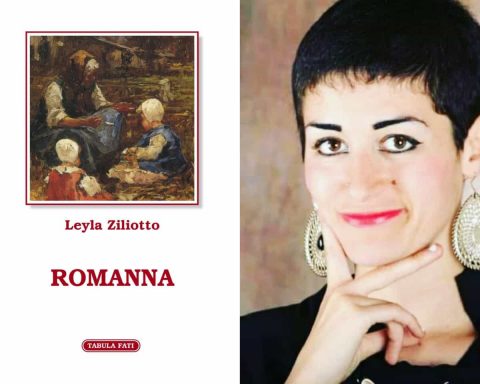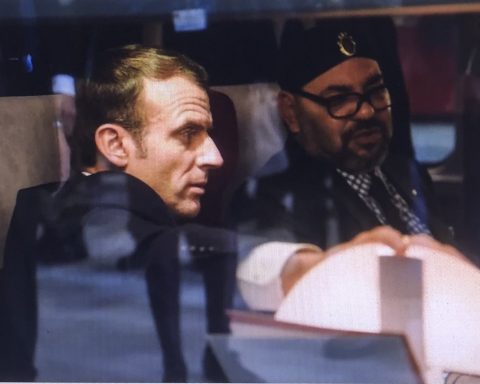Il tema dell’eutanasia, non ancora compiutamente regolamentato in Italia, continua drammaticamente a riproporsi e ad infiammare un dibattito in cui la tutela della vita si scontra con il diritto a morire
Federico, meglio conosciuto con lo pseudonimo di “Mario”, che era rimasto tetraplegico, in conseguenza di un sinistro stradale, 12 anni fa, è morto a 44 anni il 16 giugno scorso ed è il primo
cittadino italiano ad aver chiesto e ottenuto il suicidio medicalmente assistito, attraverso un macchinario che gli avrebbe consentito di morire per sua mano.
Fabio, anch’egli immobilizzato a letto da 18 anni, ha scelto la sedazione palliativa profonda e continua che lo ha accompagnato alla morte, dopo la sua richiesta di essere staccato dalle macchine che lo tenevano in vita.
Queste due storie ripropongono drammaticamente il tema dell’eutanasia, nel nostro Paese, ancora non compiutamente regolamentato e sul quale la stragrande maggioranza dei cittadini, pare oltre il 93%, chiede un’assunzione di responsabilità della classe politica.
Federico ha utilizzato la finestra creata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.242/2019, la quale ha stabilito i quattro requisiti che, allo stato dell’attuale legislazione, potrebbero giustificare un aiuto al suicidio: la presenza di una patologia irreversibile; una grave sofferenza fisica e psichica; la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli; la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.
Fabio si è avvalso della L.219/2017, che ha statuito il diritto di richiedere la sospensione di qualsiasi trattamento sanitario, compresa la nutrizione e l’idratazione artificiali, nonché la ventilazione meccanica.
Il tema è estremamente delicato e farsi condizionare dalla pietas nei confronti di chi soffre è fin troppo scontato, ma delle scelte non ideologiche e di buon senso vanno fatte.
Prima di tutto bisogna interrogarsi se la vita sia un bene appartenente esclusivamente alla persona, o sia un bene comune, da tutelare in ogni sua manifestazione. Questo è un interrogativo molto laico anche se, evidentemente, come cristiano per me è fin troppo facile dare una risposta.
Di certo uno Stato civile dovrebbe avere come sua primaria finalità quella di tutelare la vita dei propri cittadini dal primo all’ultimo giorno, e proteggere soprattutto quella dei più deboli, per cui è evidente che il riconoscere un “diritto alla morte”, come autodeterminazione dell’individuo, oltre ad essere pericolosissimo, è eticamente sbagliato. Ciò non significa che in casi veramente estremi, e con ferree garanzie, si possa ricorrere alla sedazione palliativa profonda per accompagnare alla morte.
La pericolosa china di un preteso riconoscimento del diritto a morire, sulla base dell’autodeterminazione, così come traspare dal DDL Bazzoli, può portare a conseguenze veramente aberranti.
Attenzione ad allargare le maglie della legge, ben al di là dei principi, peraltro già ampiamente permissivi, della Corte Costituzione, il percorso si farebbe veramente accidentato, fino ad arrivare a quanto si sta discutendo nella civilissima Olanda con l’ipotesi di legge della “vita completata”, per fortuna, ad oggi, solo un’ipotesi, che consentirebbe l’eutanasia “libera” per persone ultra settantacinquenni anche non malate. Ma senza arrivare a questi estremi sono preoccupanti i dati in continua ascesa nei Paesi che consentono la buona morte, basti vedere quelli del Belgio dove nel primo anno di applicazione della legge, il 2003, i casi furono 235, nel 2010 aumentarono a 953, nel 2015 a 2022 e nel 2021 a 2699, praticamente una morte su 40.
Non vi è chi non veda come il facilitare l’eutanasia sia un evidente strumento per aiutare ad eliminare tanti vecchietti che pesano sul bilancio Statale e su quello familiare.
Tornando al DDL Bazzoli le perplessità che genera sono veramente gravi, infatti il suo testo consentirebbe l’eutanasia purché la persona sia di maggiore età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, nonché portatrice di una condizione clinica irreversibile. Quindi se sono maggiorenne, non interdetto, ho delle sofferenze che io ritengo intollerabili (magari anche se oggettivamente intollerabili non sono) ed ho una malattia irreversibile, potrei tranquillamente scegliere di morire. Leggasi che anche un malato di Parkinson, probabilmente anche un diabetico o una persona affetta da tumore con prognosi infausta, ma le cui cure potrebbero allungarne notevolmente la vita, potrebbero ricorrere all’eutanasia.
È evidente che si parte da una visione miope e nichilista, dove l’uomo viene concepito avere un valore solo se ha capacità ed autonomia, in caso contrario potrà essere tranquillamente scartato dalla società, magari convincendolo che non serve più a nessuno ed è solo di peso. Questa si chiama cultura dello scarto.
Credo che si debba rivoluzionare completamente questa concezione e si debba dare pieno valore, anzi maggior valore, a chi si trova in condizioni di debolezza o di non autosufficienza, e questo anche per una forma di egoismo, in quanto, prima o poi, tutti noi, nessuno escluso, per malattia o per vecchiaia ci troveremo in quelle condizioni, e se tendiamo a scartare gli altri, qualcuno scarterà noi.
La strada maestra non ritengo sia portare alla morte, ma accompagnare ad essa ed uno Stato che possa veramente definirsi civile dovrebbe mettere al primo posto le cure palliative.
Concludo ricordando quanto sottolineato, in un recente incontro, da un eccellente medico palliativista, il dr. Salvatore Di Matteo: “Sembra una contraddizione voler curare la fine della vita, ma non lo è, perché le cure palliative hanno un nuovo paradigma di cura: non curare per guarire, ma curare per dare sollievo. E se la fondatrice di questa prospettiva, Dame Cecily Saunders, si rese conto del bisogno di una medicina specifica, proprio per tale specificità va sottolineato che le cure palliative non sono solo una impostazione scientifica accuratamente strutturata, ma ricomprendono anche il saper accompagnare il paziente come relazione. Infatti, il dolore è anche legato a uno stato sociale, cosicché le cure palliative si prendono cura della persona nella sua globalità e relazionalità e per questo serve la collaborazione di più professionisti, che sappiano ascoltare persino la famiglia del paziente. Le cure palliative sono, in sintesi, competenza e compassione e come palliativista posso affermare con certezza che ci consentono di controllare il dolore nel 100% dei casi”.
Il medesimo medico, poi, ha ricordato, dando grande speranza, che “è il dolore non controllato che genera la richiesta di eutanasia. Pertanto, se ci sono le cure palliative, le domande di eutanasia sono molto ridotte, al punto che negli ultimi anni ho incontrato nel mio reparto solo due richieste di morte da parte di persone che, avendo accettato il percorso terapeutico proposto, poi hanno anche preferito morire naturalmente”.